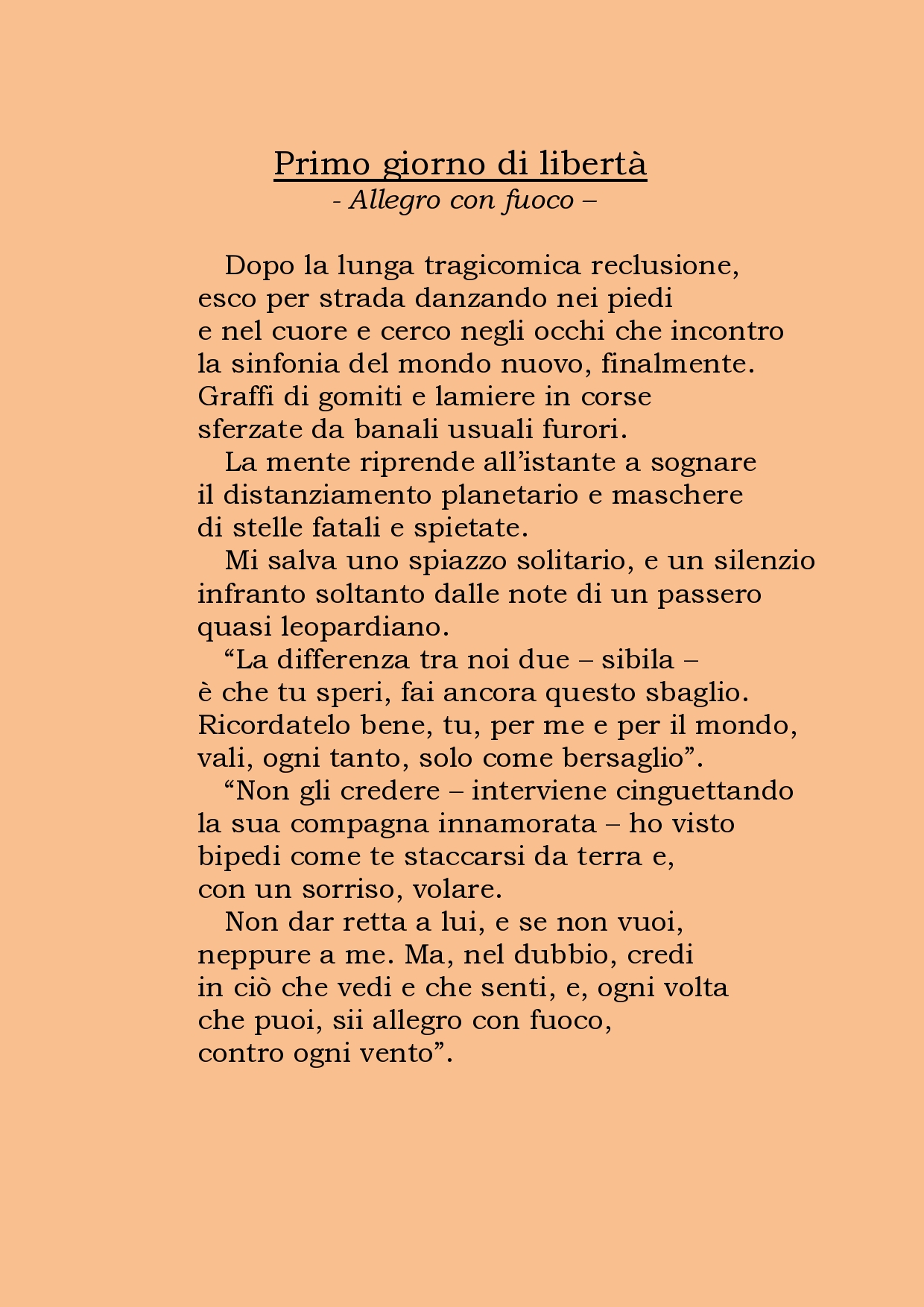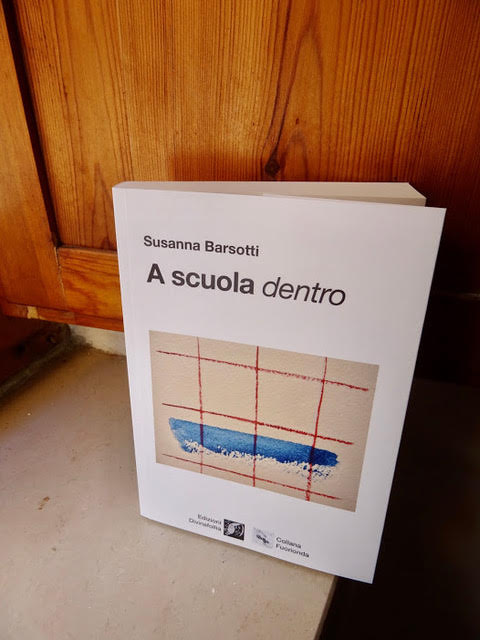Prisco De Vivo, Il lume della follia, Oèdipus Edizioni, 2019
nota di lettura di Ivano Mugnaini
È quasi ossimorico il titolo della raccolta di Prisco de Vivo. La follia è pervicacemente associata, da secoli, al buio, all’oscurità. Si tende a dire “una mente offuscata dalla follia”. Ebbene, tramite i versi e le immagini, tramite l’interazione tra la parola e la dimensione visiva (intensa in senso ampio, anche come sguardo ulteriore, al di là delle barriere preconcette), De Vivo ci propone, anzi, ci conduce a vedere il lato luminoso della follia.
Nella sua visione di credente, inoltre, la luce non può non abbinarsi in modo immediato al concetto, anzi all’atto della fede. Fede intesa, appunto, come volontà di scardinare le barriere che impediscono l’autentica comprensione tra gli esseri umani.
«Quando citi le cose del mondo che ti limitavi a tenere nascoste, mi sono sentito ancora più trascinato dentro questa tua illuminante raccolta», ha scritto Paolo Ruffilli in una nota di lettura il cui testo riporto integralmente in calce a questo mio spazio introduttivo.
Le cose, quindi, la materialità da un lato e, sul fronte opposto, la luce, qualcosa di impalpabile che tuttavia si relaziona con l’oggettualità dando vita a quella dimensione complessa e fertile che rappresenta il terreno di espressione (e di lotta) per l’estrinsecazione del sé autentico, la libertà di essere noi stessi.
Per Prisco l’opzione è insita nel coraggio di guardare con la stessa intensità la bellezza e l’orrido, il bene e il male, intersecati, tra sublime e orrifico. L’arte è conciliazione tra ricerca di perfezione e consapevolezza dell’imperfezione. Il viaggio si compie nell’atto di rendere la perfezione più umana e l’imperfezione più percepibile, più osservabile, vicina a farsi specchio in cui ognuno può cogliere, andando oltre la superficie, i propri sogni più puri e i propri demoni, le ali e le rughe che stravolgono i volti.
Il libro si basa sull’alternanza o meglio sulla coesistenza tra le idee annotate sulla pagina e la materia viva, i grumi di colore. Al punto che anche le parole assumono consistenza quasi tattile, il rilievo nodoso della sofferenza ma anche dell’energia che mira a liberarsi, liberando se stessa e chi la genera, chi la possiede chi e ne è posseduto: «scordati di me / di te / delle tue ruvide mani / che in un lampo di radice / divennero / LUCE DI SANGUE».
Per rendere più autentica e intensa l’osservazione, l’occhio deve trovare la volontà e la forza di infrangere i vetri dei preconcetti per arrivare al nucleo essenziale: «Guardo in bocca ai malati che / rompevano con i denti / i vetri delle strade / dalle loro fauci / sbucano fiori di colore vermiglio».
Il libro di De Vivo possiede una solennità mai eccessiva, mai ridondante o teatrale. Non sono quadri di maniera, quelli che dipinge con le parole e con i pennelli. Ciò gli consente di ottenere un’espressione sincera, nella sacralità del dolore, che tuttavia non è descritto come oggetto intoccabile, ma, al contrario, è umanizzato. La disperazione, al di là di infiniti e tortuosi percorsi, può sfociare in uno spazio diverso: «Quando riuscirò a morire veramente / liberandomi dall’inferno, / delle colonne coclidi, / dal polistirolo dei farmaci / dalla dissenteria dell’anima».
L’impressione è che De Vivo abbia scritto questo libro con estrema sincerità, non per aggiungere un titolo alla sua bibliografia. Tale autenticità gli ha permesso di scrutare l’abisso senza perdersi, senza smarrire lo sguardo e la voce. Gli ha consentito, per quanto umanamente possibile, di giungere all’immedesimazione con il dolore più lacerante e vero, ma anche con la forza vitale e creativa, fuoco e lava di vulcano. Quella che, a dispetto di tutto, a tratti, magari in imprevedibili istanti, può condurre al punto più estremo al cui fondo c’è la rinascita, o meglio la nascita a vita vera.
IM

§§§§§§§§§§
UNA NOTA DI LETTURA A “IL LUME DELLA FOLLIA”
Punteggiate dai tuoi incisivi disegni, le tue intense poesie colpiscono e coinvolgono quasi a specchio sorprendente della situazione drammatica in cui adesso ci troviamo a vivere e con l’effetto che le tue presenze familiari trapassano in figure universali di ieri e di oggi.
E, quando citi le cose del mondo che ti limitavi a tenere nascoste, mi sono sentito ancora più trascinato dentro questa tua illuminante raccolta.
Colpito anche dal continuo intervenire tra le righe e in epigrafe di scrittori anche per me di riferimento.
Paolo Ruffilli
§§§§§§§§§§
NOTA BIO-BIBLIOGRAFICA
Prisco De Vivo è pittore, scultore e poeta. È nato a Napoli nel 1971 e vive ad Avellino. Ha pubblicato i volumi di poesie: Dell’amore del sangue e del ricordo (selezionato al Premio Pascoli 2005) (Il Laboratorio/Le edizioni, 2004, prefazione di Plinio Perilli e postfazione di Raffaele Piazza), Segni e parole (In una notte oscura e uggiosa) (Il Laboratorio/Le edizioni, 2006, lavoro di poesia/immagini a quattro mani con Raffaele Piazza), Dalla penultima soglia (Marcus edizioni, 2008, prefazione di Marcello Carlino), Ad Auschwitz (Il Laboratorio/le edizioni, 2009, prefazione di Enzo Rega e postfazione di Antonella Cilento), ha ricevuto per la raccolta Il lume della follia il secondo posto del Premio Nazionale Minturnae XXIII edizione per l’inedito, 2009.
È stato incluso in varie antologie tra cui: Melodia della terra (Secondo Volume) 2006 (Crocetti editore, a cura di Plinio Perilli), Da Napoli, Verso Kairos editore, a cura di Antonio Spagnuolo e Stelvio Di Di Spigno) 2007 (Poeti e Pittori di [Secondo Tempo] 2013 Marcus Edizioni, a cura di Alessandro Carandente e Marcello Carlino).
Le recensioni sui suoi testi poetici e le sue poesie sono apparsi su: Poiesis, Risvolti, La Clessidra, Pagine, Gradiva, La Mosca di Milano, Secondo Tempo, Capoverso, Poesia, Repubblica, La Stampa, Il Mattino, Sinestesie, Zeta, Cenobio, Trimbi, Clandestino, Graphie, Poeti e Poesia, Frequenze Poetiche.
Ha collaborato a diversi periodici e riviste d’arte e letteratura, italiane e straniere, cartacee ed on-line, inoltre è stato presente a mostre di poesia visuale e recitals poetici.
Si è occupato di saggistica, scrivendo su poeti come: Pier Paolo Pasolini, Dario Bellezza, Camillo Capolongo, Guido Ceronetti, Rubina Giorgi. Nel 2020 ha pubblicato il volume di poesie e immagini Il lume della follia Oèdipus edizioni.
https://www.rivistaclandestino.com/guido-ceronetti-il-vetusto-e-geniale-maestro-del-pensiero-terribile/
http://frequenzepoetiche.altervista.org/prisco-de-vivo
http://www.cinquecolonne.it//26/5/2019/poeti-in-Campania-prisco-de-vivo
http://www.rivistaea.it/18/7/2018-la-promessa-di-orfeo/prisco-de-vivo
http://www.facebook.com/priscodevivo/
CONTATTI : info@priscodevivo.it