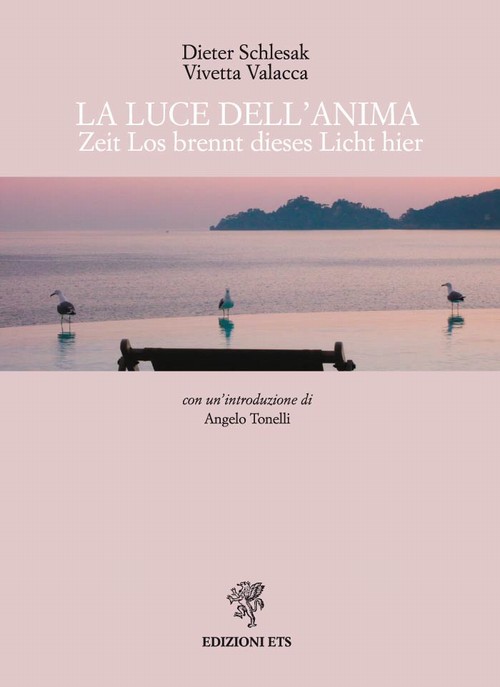Per la rubrica RITRATTI IMPROPRI, una follia primaverile: dare voce alla musica di Chopin, al suo Ultimo Notturno.
IM


CHOPIN- Il buio e l’aurora
L’uomo è un dio
quando sogna,
un mendicante
quando riflette
F. Hölderlin, Iperione
La mia corsa con la vita prosegue da sempre. Fin dal momento in cui ho percepito per la prima volta i suoni e le immagini. Ho iniziato a comporre da bambino. “Il nuovo Mozart”, mi chiamavano, “il talento più precoce dell’epoca”. Certo. Più precoce della gioventù. Non ho avuto il tempo di imparare a non imparare, la follia priva di scopo e utilità. Ora devo dare misura al mio amore per il buio. Tentare una sintesi tra verità e menzogna. Me lo impone il tempo, ancora lui. Devo scrivere il mio ultimo “Notturno”, la lettera di addio al mondo e a me stesso.
Non ho mai amato parlare di me. Ma devo raccontarmi, adesso, con parole che siano cristalline anche per gli altri. Rapide a svanire come un tramonto inghiottito dalla notte. Con qualcosa che resta: il senso, l’assenza di una logica, la bellezza che non sai afferrare anche se le corri incontro. È lei che viene da te, a sorpresa, a tradimento, dolorosa, lieve. La risposta. Forse.
Mi chiamo Fryderyk Chopin. La mia terra è la Polonia, anche se molti mi considerano francese. Molti, a dire il vero, mi considerano un’infinità di cose che non sono. Non è colpa loro. O, almeno, non è solo loro, la colpa. Una loro affermazione, comunque, la condivido. “Non somigli a nessuno”, mi ripetono. Ineccepibile. Posso assicurarvi che non è stata una scelta. Direi piuttosto una necessità. Ho dovuto staccare i contatti con il passato e il presente. Per inventare un suono solo mio. Ha ragione Schumann quando sostiene che la mia musica si riconosce perfino nelle pause, nell’alternanza di presenza e assenza, concreto e immaginario. Lì, in quegli spazi vuoti, ho stillato l’essenza: ciò che amo infinitamente e ciò che odio con tutto me stesso.
Ho avuto poche certezze. Ancora più raramente ho saputo renderle nitide. Avrei dato la vita per essere capace di lottare per ciò in cui credo. Per l’indipendenza del mio paese soggiogato dall’oppressione straniera, innanzitutto. Ma hanno ritenuto che fossi sprecato su un campo di battaglia o dietro una barricata. “Pensa quale perdita! Per la musica! Per l’arte!”. E così sono fuggito, di paese in paese, suonando e sorridendo senza tregua, strozzato da camicie inamidate e dai lacci della sconfitta, la viltà, l’esilio. Ho accettato un gioco che mi faceva comodo; mi uccideva in modo liscio, nel caldo delle stanze, nell’ovatta degli sguardi. Ho lasciato che il mio corpo si indebolisse progressivamente, le braccia sempre più esili, le spalle ossute, i polmoni consunti. Faceva chic, mi dava un contegno da vero artista. Soffrire, sì, ma in saloni di lusso con il caminetto acceso e i vassoi d’argento stracolmi di pasticcini profumati. Lontano dal fango e dal sangue, dal battito di piombo dei fucili che feriva l’aria delle trincee dove morivano i miei fratelli.
Sono nato e vissuto in un’epoca di guerra, di sopraffazione. Liberare il mio popolo avrebbe significato liberare l’intera umanità. Liberare me. Me, in ogni uomo. Non ho mai amato la folla, questo è vero. Ma ho provato affetto per i singoli individui, per ciò che di grande e sacro si trova, a tratti, in ciascuno.
Ho amato le donne, immensamente. Diverse tra loro, ognuna un profumo, un angolo della bocca, un riso, concerto di divine sciocchezze e carnali verità. Un ghigno aspro e bambino che si apre in un abbraccio. Ferita e balsamo.
Maria, prima di tutto e di tutte. L’ho conosciuta nella splendida Dresda. Mi ha sorriso timida e sfrontata, lei, la più piccola delle sorelle Wodzinskj. “Troppo giovane per te”, mi dicevano. Ma non l’avevano ascoltata cantare, non l’avevano sentita, loro. Era l’eterno femminino, l’amore di sempre strappato con la fantasia alle dita del nulla. Maria, il mio dolore. Un fascicolo di lettere scritte con l’entusiasmo della gioventù. L’ingenuità che racchiude il solo senso concesso ad un uomo. Tutta la speranza di vita nel pensiero di lei. Ora quelle lettere le ho legate con un nastro su cui ho scritto due scarne parole: “My sorrow”, il mio dolore. Per follia ulteriore, o per un misero tentativo di fuga, le ho scritte in inglese. Come se esprimerle in una lingua non mia le rendesse meno vere, meno spietate. Un po’ come camuffare un violino con un contrabbasso. Tentativo vano, velleitario.

Il vero è riemerso, con un colpo di tamburo sgraziato. I genitori di lei mi hanno respinto, non mi hanno ritenuto all’altezza di sposarla, di darle la felicità. La ragione ufficiale che hanno addotto è stata la gracilità del mio fisico e l’instabilità della mia salute. In realtà hanno saputo guardare più a fondo. Sono andati ben oltre le costole, le vene e il respiro. Hanno colto l’esilità della mia normalità: l’incapacità di stare in piedi, lontano dal pianoforte, nel vento gelido della vita vera.
Al termine della notte del mio dolore è comparsa lei, Aurore. Ricca, colta, matura. L’esatto opposto di Maria, accomunata al mio primo amore solo dal fascino lacerante, il potere di scrutarmi nella mente. Aurore Dupin, alias George Sand. Alias tutto e alias niente. Lei sola. Ineluttabile. Mi avrebbe amato, Aurore, senza il mio “talento”? La domanda è assurda, fuori logica, fuori spartito. È giusto chiedermi, semmai, cosa so io, cosa ho compreso di lei. La sua età, il suo nome, ogni cosa è incerta. Non il suo corpo, l’affetto ruvido e tenero che mi ha dato incondizionatamente.
Mi ha portato fuori da me. Nel sole, nell’aria, nell’umidità che mi hanno salvato, uccidendomi, e mi hanno ucciso, salvandomi. Nell’isola di Maiorca. Alla fine, nonostante le ottime intenzioni, si è rivelato il luogo meno adatto al mondo per me, per i miei polmoni minati dal male. Sono morto a poco a poco. Morto di vita, di risa, di abbracci leggeri e disperati fino a perdere il confine dei corpi, fino a non sapere più se stringevo Aurore, George, il bene, il male, me stesso, l’opposto di me. Ignoravo con ebbrezza infinita quale fosse l’ordine, il punto cardinale, verdetto di una bussola che non segnava alcun punto fisso. Lei era lì. L’oceano e l’isola della mia vita. Tutto il resto era silenzio. Ero libero. Anche di morire, certo. Facendo del mio corpo un pentagramma di linfa che freme. Non più solo l’idea, la scansione del tempo su frequenze impalpabili. Ero divenuto l’antipode, il contrario di me. E l’autentico me stesso. Una musica: carne e vibrazioni.

Ho scordato l’amore per l’isolamento, le labbra della solitudine. Ho lasciato che a succhiarmi goccia a goccia il sangue fosse la donna che lo rendeva caldo, ustionante, grido fluido nelle vene. Ho smesso, con Aurore, di essere romanticamente spento, alloro su rovine fatiscenti. Ho potuto sussurrare, sbraitare, ascoltare frasi rosse e taglienti come lame su guance di passione. Ho composto, sulla carta e sulla pelle, slanci disperati e suadenti. Un vigore sfociato in violenze sane, avide di scorrere sempre e soltanto nell’alveo dell’amore. Mi sono sentito, con lei, un insieme di voci. Per questa ragione ho voluto servirmi raramente dell’orchestra nelle mie composizioni. Un pianoforte è tutto, contiene in sé gli estremi. Basta sfiorarlo o penetrarlo nel profondo. Aurore è stata il mio pianoforte. L’universo alla portata delle braccia.
Solo un poeta poteva essere in grado di comprendere, cogliere l’ossimoro, la miscela esplosiva di creazione e distruzione. Tale alchimia l’ha ritratta tramite le parole Charles Baudelaire. Ha colto l’arcano, il dettaglio e la prospettiva, definendo la mia musica “leggera e appassionata come un falco scintillante che volteggia sugli orrori dell’abisso”.

Le note, il piano, il rimpianto e la felicità del ricordo di Maria. E ancora, dentro e al di sopra di tutto, Aurore, la luce del mio abisso. L’ho amata fino a odiarla. Disprezzandola con amore sconfinato, quando mi sfuggiva, si chiudeva nelle mura del suo egoismo, i suoi racconti, storie a me estranee. Ma perfino il suo egoismo era una forma d’amore. L’ho capito, adesso. Aurore mi ha strappato alla culla dei miei sogni, la vita perfetta e fatua che mi era toccata in sorte. Avrei voluto dirle ciò che merita, le frasi che cerco di pronunciare da sempre, quelle che mai, neppure ora, saprei dirle fissandola negli occhi. “Ti sei la porta del Paradiso. Per te rinuncerei alla fama, al genio, qualunque cosa sia. A tutto”. Forse riderebbe, si commuoverebbe, o magari mi farebbe tacere con un bacio più eloquente di ogni discorso. Con lei ho imparato ad apprezzare le cose semplici, il vino, le castagne, le danze del popolo, mazurche sanguigne accompagnate da stille di sudore che sa di abbracci, grappoli da spremere, farina da impastare con le mani.
Aurore è diventata la mia patria, lo confesso, non senza vergogna. Ho pagato. L’esilio è una morsa che stritola in silenzio. Spezza le ossa, soprattutto in certi momenti di serenità falsa, stranita. Lei è sempre al mio fianco. Dura, dolcissima. Mi ha strappato alle prigioni della mente portandomi nei confini della sua terra. A Nohant, nella Francia che per me è destino, sogno che torna a farsi terra. Là ho potuto comporre a ritmi folli, in una febbre che bruciava e faceva musica del dolore di un’impudica felicità. Ho scritto finché ho potuto, provando a tenere il passo del cuore. Alla fine l’inverno è tornato. Il figlio di Aurore, il suo amore legittimo, mi ha allontanato da Nohant. Ed ha richiamato la madre a sé, al suo mondo. Mi sono riaccostato alla mia patria polacca e alla patria finale, la meta di ogni viaggio, dando il mio ultimo concerto a Londra per i rifugiati polacchi. Il cerchio si è chiuso. La verità ha raggiunto il sogno. Hanno sincronizzato gli attacchi e gli accordi, il battere e il levare.
È tempo per me di tirare le fila, cogliere le Corrispondenze profonde. Mi permetto un ultimo Scherzo, un gioco estremo, quasi amichevole, con Madame La Morte. Proprio a lei dedicherò il mio Ultimo Notturno. Non perché lei rappresenti la fine ineluttabile del cammino. Anzi. Proprio perché, paradossalmente ma neppure troppo, il suo nulla non conclude, non risolve. Non perché io speri in sconti di pena o in prospettive ulteriori. Semplicemente perché, nonostante la sua presenza ingombrante, maldestra, l’uomo continua a volare, falco scintillante su paradisi e abissi.
Scriverò a lei, alla nera signora, la mia lettera finale. Per dirle che i miei ultimi componimenti saranno dedicati a “Le printemps” e a “Le souhaite d’une jeune fille”. Alla Primavera e al Desiderio di una Ragazza. Potrà avermi solo da vivo, la morte. E l’ultimissimo componimento sarà “Chant du Tombeau”. Anche la tomba sarà un Canto. Perché è vero, ancora una volta i poeti danno voce alla realtà più intensa e scomoda: “L’uomo è un dio quando sogna e un mendicante quando riflette”. Si può trovare l’alba anche nel buio, la luce nel Notturno più cupo.
Con la morte sarò sincero. Lo merita. Lei lo è di sicuro, schietta, diretta. Lo sarò anch’io. Finalmente me stesso. Mi scoverà, la sua mano ossuta, mi farà venire allo scoperto e mi trascinerà via. Solo in parte però. Resterà la musica, Maria, Aurore, la purezza, la passione. Con loro sono riuscito a dire cos’è un tramonto, la neve sulle colline, l’afa che toglie il fiato, il gelo e il tepore del sangue. Malinconie che corteggiano gioie fanciulle. E se anche non fossi riuscito a dirlo appieno, ad esprimerlo in modo compiuto, ho ancora note da intrecciare, un Notturno da completare. Capace di echeggiare dentro di me. La comprensione dell’ineffabile: una musica che sfida l’abisso. Ali fragili e tenaci spaziano nell’orizzonte oscuro e luminoso di un pianoforte.