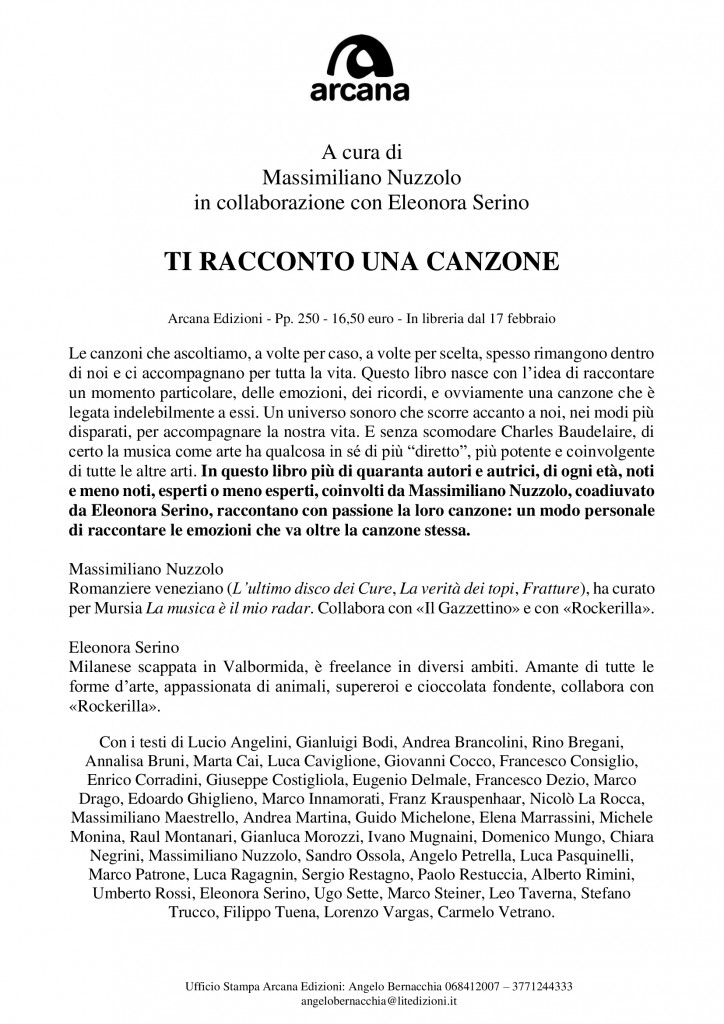UT – IL PRINCIPIO ED IL FINE

Marco Capponi è un autore in grado di abbinare l’inventiva ricca di immaginazione con un rigore logico-sintattico che gli deriva anche dai suoi studi e dalle attività professionali che ha svolto. Questo abbinamento si è confermato nei suoi romanzi di recente uscita LE RAGIONI DEL CASO E DEL DESTINO e ESTINZIONE entrambi editi dalle Edizioni Divinafollia. Ma è sempre stato presente nel suo percorso letterario ed è rilevabile anche nel romanzo UT – IL PRINCIPIO ED IL FINE. Questo libro è stato pubblicato nel 2012 per i tipi di Marte Editrice ed è stato scritto assieme a Manuela Litro, concertista e musicista, oltre che scrittrice. Nonostante il diverso percorso dei due autori, la loro diversa impostazione e le esperienze artistiche e professionali in ambiti differenti, il romanzo dimostra una coesione apprezzabile, un amalgama omogeneo di toni, note, approcci, canti e controcanti, luci e chiaroscuri. Lo spunto iniziale è accattivante e coinvolgente: il segreto legato ad un misterioso libretto d’opera acquistato in un’asta a Ginevra. A partire da questa brillante ma anche arcana scintilla iniziale la storia si dipana con un ritmo serrato tra ambienti vari e domini contrastanti. Il merito di questo libro è proprio questa volontà di superare le barriere tra ambiti che vengono spesso ritenuti separati e in realtà sono contigui, spesso convergenti, di sicuro in un rapporto dialogico, tanto più intenso quanto più intricato.
Si tratta di un romanzo di non facile e immediata lettura, lontano dalla cantilenante e prevedibile orecchiabilità di certi lavori preconfezionati. In questo libro i due autori hanno scavato nei meandri di una vicenda che in fondo funge da specchio per lo studio di meccanismi di più ampio respiro, come il rapporto tra arte e scienza, verità e menzogna, e, in fondo, in ultima ma predominante istanza, su quello che è e permane il più vivido mistero, quello dei rapporti tra gli uomini, affetto, amore, amicizia, dialogo profondo; un libretto d’opera da comporre giorno dopo giorno con gli accordi che è necessario scrivere secondo ispirazioni mutevoli e autentiche, non mutuabili da nessun modello di riferimento. In questo consiste l’interesse di questo romanzo, nel principio ed il fine a cui fa riferimento il titolo, quel mistero nel mistero che è necessario indagare, sapendo che il finale, fatalmente ma anche per fortuna, è aperto, denso di potenzialità ulteriori.


Parto da qui, da queste note (mi sembra consono l’utilizzo di questo vocabolo così polivalente e polisemico) scritte per il mio blog Dedalus nell’ormai lontano gennaio del 2013. Il tempo è una dimensione con cui dobbiamo fare i conti sempre, è il fardello ed il dono, e anche di questo si parla in questo libro, così come in altri volumi di Capponi, tra cui i già citati LE RAGIONI DEL CASO E DEL DESTINO e, in particolare, nel recentissimo ESTINZIONE, romanzo che ha avuto ottimi riscontri e ottenuto attenzione in importanti riviste, anche on line. Ma per non disperderci, e per non perdere tempo, risultando in tal modo del tutto contraddittori, direi di concentrarci, qui ed ora, hic et nunc (il latino ha sempre un suo fascino) sul libro odierno, UT. Il tema del tempo, topos per eccellenza, croce e delizia di chiunque scriva, letteratura, filosofia, o qualsiasi altra disciplina cosiddetta umanistica, ma anche e soprattutto tema fondamentale per qualunque disciplina umana, ossia di ogni essere dotato di capacità di sentire e ragionare, si affaccia in modo deciso ed evidente fin dalla copertina. Il sottotitolo, o meglio la parte analitica e allo stesso tempo intrigante, allusiva e metaforica del titolo è IL PRINCIPIO ED IL FINE. Già qui si rileva uno di quei giochi mentali, una di quelle fondamentali sottigliezze che costituiscono il succo, l’essenza di questo libro. Viene indicato che il termine esatto è “il fine”, ma, in modo spontaneo, la nostra mente associa al principio “la fine”. Non è solo una contrapposizione di genere, di quelle che vanno sempre di moda, perfino in ambito grammaticale. Qui c’è una distinzione che allo stesso tempo separa ed attrae. La dicitura è chiara, “il fine”, ossia lo scopo, la meta, il traguardo da ottenere. Ma la chiarezza, nella letteratura, e forse anche nella scienza, o almeno in quella scienza umana e perfettibile di cui abbiamo parlato, lascia sempre uno spiraglio aperto a luci e chiaroscuri. Qui ci viene detto di non pensare alla fine ma al fine e tuttavia escludendo il pensiero del termine (nel senso di conclusione, anche del tempo) lo si evoca e quindi gli si dà forma e sostanza.
Il fine non è la fine, e tuttavia in qualche misura lo è, fosse pure nella volontà di affermare o meglio suggerire che il fine è quello di evitarla la fine, sia essa la fine definitiva che la fine intesa come perdita di senso, smarrimento di verità, di coerenza, di linearità progressiva di una trama, della vicenda specifica narrata nel libro e in senso più ampio e onnicomprensivo nella metafora esistenziale e artistica che sottende. Samuel Beckett affermava che “è tutta una questione di tempo. Quello che accade sono delle parole”. Parafrasandolo, potremmo dire che quello che accade qui, nello spazio e nel tempo di questo romanzo, è il tempo stesso. La riflessione sul tempo umano, sul senso del bello e sul furto della bellezza, sia in senso concreto che simbolico. Parafrasando l’autore irlandese potremmo dire che quello che accade nel tempo di questo libro è il tempo. E qui, per forza e per amore (come cantano i contradaioli del Palio di Siena) entra in ballo, e in azione, la musica. La musica è sostanzialmente, intimamente, essenzialmente, tempo. Rappresenta il sogno e la volontà umana di dare misura vivibile al tempo, tramutandolo in un sogno reale. Rappresenta il desiderio di imprigionare Cronos in schemi riproducili, sapendo che ciò non sarà mai possibile, se non all’interno di una dimensione onirica, squisitamente umana, che si chiama armonia.
Il libro contiene moltissimi riferimenti alla musica. Potremmo dire che, oltre al ritmo della narrazione, c’è un sottofondo costante, un accompagnamento quasi filmico, cinematografico, una colonna sonora o una sinfonia che muta, alternando ritmi e movimenti. Ma UT è anche un soprattutto un libro in cui si ragiona, si riflette, e si sa, lo sanno gli studenti che ascoltano Mozart mentre studiano matematica, niente come la musica è adatto e utile al ragionamento. Ciò che appare incorporeo, impalpabile, in realtà ha una sostanza che perfettamente ricalca, e in qualche modo genera e forgia, i pensieri, sia scientifici che filosofici, letterari, logici e creativi.
Si ragiona sulla musica in questo libro, mentre la musica scandisce eventi e mutamenti, rincorse e ricerche, di oggetti concreti e di pensieri. Tra i molti esempi possibili, tra le numerose variazioni sul tema, mi piace citare l’excursus di pagina 92 in cui si parte dalla mousike paideia per poi addentrarsi nel diverso destino avuto dalla musica in diverse epoche e differenti regimi, per poi passare ad una disanima dettagliata dei problemi di teoria musicale, dei musicisti adepti di associazioni segrete, dei molteplici livelli di lettura di un brano e via dicendo. La musica, dunque, non solo come sfondo o tappeto su cui si muovono i protagonisti e gli accadimenti, ma anche, e forse soprattutto, come riferimento simbolico, mondo parallelo e tuttavia presente, potremmo dire concreto, di sicuro efficace, sul piano anche della prassi, per il modo in cui influenza le azioni dei personaggi e anche per la valenza metaforica e interpretativa che assume. Quando leggiamo ad esempio il riferimento ai molteplici livelli di lettura di un brano, viene fatto di pensare, in modo spontaneo e pressoché immediato, anche ai diversi modi di leggere i brani del libro stesso, e del mondo che narra, evoca e descrive.

Il mondo è quello dell’arte. Intesa in senso ampio e multiforme. Variegato sia per le diverse discipline e gli ambiti che vengono indicati nel corso della vicenda spaziando dalle arti figurative a quelle musicali sia per la volontà e la capacità di suggerire che il discorso artistico non si esaurisce nell’atto della mera esecuzione, nella visione e nell’ascolto, ma si estende e si integra con altri livelli del pensare e del vivere. Si integrano, le arti creative, con quelle che in modo schematico e in gran parte inappropriato vengono definite “scienze esatte”.
Il compito di questo libro, il suo principio ed il suo fine, la sfida che intraprende con serena e determinata passione, è quello di superare uno steccato, o meglio di mostrare che lo steccato in realtà non esiste, non ha consistenza, non ha neppure la stessa sostanza dei sogni, per dirla con Shakespeare, perché, in realtà, il sogno concreto che si chiama vita dimostra che non esiste confine rilevabile tra arte e ragionamento, tra creatività e riflessione.
Questa è la trama ulteriore, il progetto e la meta di questo libro di Marco Capponi e Manuela Litro. Mostrare il dialogo che sussiste in potenza e in atto, tra scienza e arte, matematica e musica, sentimento e follia, come recita la quarta di copertina, e non specifica, perché è impossibile determinarlo, da che parte, su quale versante si trovi il sentimento e da quale la follia. Entrambi vivono e dialogano su tutti e due i fronti. E nell’atto di incontrarsi, perdono la loro connotazione e si mischiano, diventano spuri e impuri, e in tal modo completi, organismi perfetti.
La sfida di questo libro è stata quella di fare incontrare due mondi diversi su uno stesso piano (e anche stavolta la polisemia del termine non può che giungere gradita). Il piano di un pianoforte è fatto di contrasti, di bianco e di nero, di forte e di piano, di alti e di bassi, ma, soprattutto di accordi, infiniti, potenzialmente illimitati: suonare e scrivere a quattro mani, con tutta la difficoltà e la magia che questo gesto contiene. Marco e Manuela hanno accettato questa sfida, prima di tutto con loro stessi. L’hanno accettata con un sorriso, con serietà assoluta ma anche evitando seriosità stridenti e cacofoniche e schivando con cura la tentazione di proporre una predica cantata fuori luogo e fuori tempo.
Nessuno dei due si è snaturato né ha preteso di modificare l’interlocutore. Capponi è rimasto uno scienziato con una vena naturale per la scrittura narrativa, o un narratore con una vena per la scienza, fate voi, e Manuela Litro è rimasta una musicista con la capacità di divulgare arte, di farne discorso aperto per la gente, nutrimento a cui invita ad avvicinarsi.
Le qualità narrative di Capponi, la prosa solida e tuttavia scorrevole, si evidenziano in modo costante nell’intero libro. Gli esempi possibili sono numerosissimi, ma, anche per uno dei tanti riferimenti a dualismi emblematici, si segnala tra gli altri il brano che inizia a pagina 38 e che ha il suo culmine a pagina 40, là dove si discute della “drammatica crisi della Ragione”. L’impegno di Capponi, politico ma prima di tutto umano, umanistico potremmo dire, finalizzato a conservare la bellezza e la “vivibilità” anche nell’ambito del sociale, si riflette, tra le righe, in modo implicito ma rilevabile, anche nelle pagine di questo testo che tuttavia, è giusto ribadirlo, ha un impianto assolutamente narrativo. Ma in ogni storia raccontata, Capponi lo sa e lo mette in pratica, si celano elementi per provare a riflettere su un giallo di più ampia portata, quello della Storia con la s maiuscola, che non di rado di maiuscolo ha soltanto l’incomprensibile ferocia e la totale mancanza di ragione, equità e giustizia. E questo in ogni epoca. Sarebbe bello poter dire che ciò che non accade nella nostra, non accade qui ed ora. Ma il riso che ne deriverebbe sarebbe una prova efficace del contrario.
“Ogni nota ha armoniche più acute o più gravi che si ottengono moltiplicando o dividendo per due, per quattro eccetera la lunghezza originaria della corda. L’intervallo tra due note armoniche successive è quello che noi chiamiamo ‘ottava’”. Questo brano fa parte di una postilla, di una nota (ancora un gioco del linguaggio rivelatore) contenuta nelle pagine comprese tra 81 e 84, dove si cita Pitagora e si parla di lunghezze, di frequenze, di suono e di ascolto. Manuela Litro, esperta cultrice di musica, ha saputo porre qui e altrove, in tutto il volume, le sue conoscenze al servizio di una storia, di un racconto. Ha cadenzato le diverse fasi, potremmo dire le scene, facendo un parallelismo sia con il cinema che con il teatro, utilizzando le cadenze sia per dare ritmo alla narrazione sia per creare quella completa e suggestiva interazione tra il mondo della parola e quello dei suoni, tra l’arte della visione, della pittura e della lettura, e quella dell’ascolto. La risultante, potremmo dire il risultato aritmetico di tale prodotto, è, appunto, una fusione del tutto coesa tra la musica e la matematica, ossia tra la malia delle note e quella logica che è insita sia in un ragionamento matematico sia in un intreccio narrativo, in un racconto, in special modo in un racconto come quello di UT basato su un mistero, un nodo da svelare tramite una sequenza di indizi da indagare e su cui riflettere cercando di ricavarne una spiegazione plausibile.

Il libro è ottimamente costruito, anche a livello di intreccio, e sarebbe uno sgarbo ben poco armonico nei confronti dei lettori rivelarne la trama. Lasciamo a chi è interessato il gusto e il compito di esplorare passo dopo passo l’universo concreto e quello immaginario, le città e i luoghi, i gesti e le riflessioni che si susseguono.
Ciò che possiamo fare è ribadire e confermare molto volentieri che questo libro, di non facile assimilazione, lascia tuttavia a chi lo legge il gusto che regalano le narrazioni di sostanza, quelle in cui non ci si limita a mettere in fila una serie di fatti e di azioni ma ci si ritaglia anche il tempo per andare oltre la superficie, esplorando le sensazioni che nascono e cercando sia le radici, vale a dire le citazioni di libri e opere del passato, sia le proiezioni, pensando a possibili scenari futuri, e, valore aggiunto di assoluto rilievo, la riflessione sul senso del vivere, sulla condizione di esseri pensanti che sono in grado allo stesso tempo di generare la Nona Sinfonia o un bombardamento a tappeto su una popolazione inerme, tele mirabili o sgorbi privi di senso, armonia oppure frastuono assurdo e assordante.
È un libro che racconta un incontro, una ricerca, un percorso condiviso tra due esseri umani diversi eppure affini, e, assieme, narra il tentativo ininterrotto di tutta l’umanità di conciliare bellezza e dolore, verità e dubbio, il principio ed il fine, ciò che davvero siamo e ciò vorremmo e potremmo essere, o diventare.

Marco Capponi nasce a Ripatransone (A.P) nel 1944. Laureato in Fisica Generale ha insegnato Fisica alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna ed ha svolto attività scientifiche presso laboratori nazionali ed internazionali tra i quali il CERN di Ginevra, il CEN di Saclay e i Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Nel 2008 ha pubblicato il suo primo romanzo “l’opinabile vita” con la Bononia University Press. Nel 1912 esce per Marte Editrice “UT”, scritto con la musicista Manuela Liiro. Nel 2014 “Le ragioni del caso e del destino” con la editrice Divinafollia.
Manuela Litro, genovese, è diplomata in canto lirico e teatro musicale. Concertista con il “Ring Around Quartet”, ensemble vocale di polifonia rinascimentale, si esibisce nelle principali stagioni di musica da camera e festival di musica antica. Ideatrice e curatrice del progetto Carillon del MIUR in collaborazione con il Conservatorio Santa Cecilia – musica per prevenire e contrastare fenomeni di disagio giovanile – dirige il coro multietnico Manin, che si è esibito più volte alla Rai ed in cerimonie ufficiali al Quirinale.
È inoltre antiquaria ed esperta di dipinti del XIX secolo.