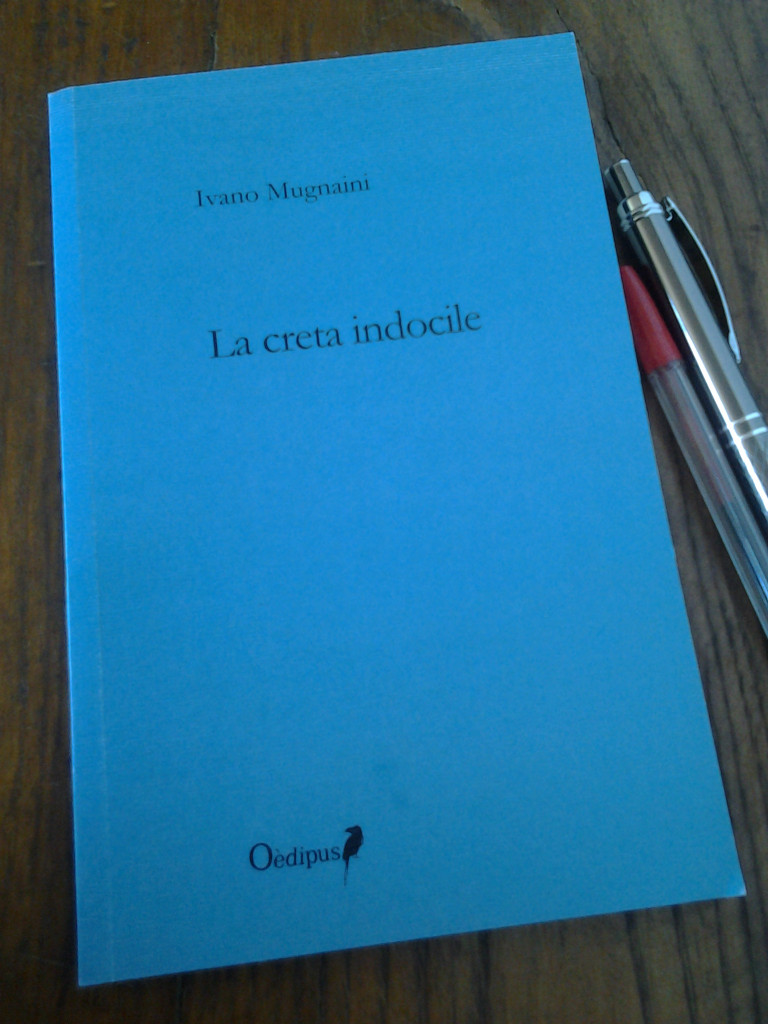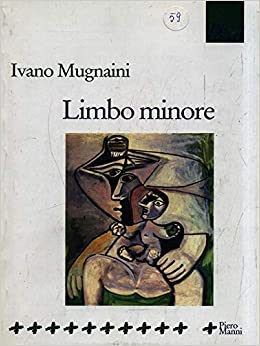Archivi tag: Enea
Altri rami e altri frutti – Seeds, Chelsea Editions, New York, 2014

Adam Vaccaro, Seeds, Chelsea Editions, New York, 2014
Avere semi, reali o poetici, implica un percorso, esso stesso reale e metaforico, simbolico, strettamente correlati. Il percorso nasce dalle radici e ad esse, ossia alla terra, ritorna, per poi ridare a sua volta vita ad altri rami e altri frutti. Altri semi, in una ciclicità vitale.
Le radici di Adam Vaccaro, tracciate anche in questo suo libro, sono quelle del Molise. Terra di confine, difficile, aspra. Lascia, spesso, solo la soluzione del viaggio, dello spostamento verso altri orizzonti.
Non è un caso che questo libro, che parla di semi, quindi di radicamento in un suolo, in realtà sia anche, simultaneamente, un libro di viaggi, reali o sognati, concreti o letterari, fino al punto in cui anche il viaggio mitico, quello di Ulisse o di Enea o di altri uomini che hanno esplorato i mari, le terre e il loro mondo interiore, diventa esso stesso reale, o meglio vissuto, come un evento concreto, tangibile, assimilato al punto da favorire una completa immedesimazione.
Il libro è un lungo diario di bordo con le varie tappe scandite da precisi riferimenti, annotazioni, schizzi descrittivi delle genti incontrate, dei gesti, degli scambi, di parole, di sensazioni, di emozioni.
È un libro in cui si registra, con preciso ma intenso stupore, quella che è una delle mete che Vaccaro, come poeta e come uomo, ha sempre tenacemente inseguito: la adiacenza. Concetto anche questo tangibile, reso carne pulsante, non concetto sterile e astratto. Adiacenza non significa semplicemente vicinanza, non vuol dire soltanto trovarsi accanto in un luogo, significa piuttosto condivisione profonda, di un ideale, una tensione, una volontà di conservare qualcosa e modificare qualcos’altro: conservare quella radici di cui si è detto, quelle di un mondo contadino fatto di autenticità e allo stesso tempo modificare il presente tramutandolo in un futuro più umano, più solidale.
Tutto ciò avviene in modo fattivo, sia nel libro che nella pratica quotidiana messa in atto da Vaccaro, non con proclami altisonanti ma astratti. Con una ben motivata concretezza, piuttosto, con parole nitide, lente, da slow food, verrebbe da dire, con la consapevolezza che solo ciò che ha un punto di appoggio solido può generare pensieri solidi e al contempo sogni, non impalpabili ma percorribili, come strade, come solchi di aratro.
Il libro, tradotto e curato nella versione inglese da Sean Mark, acquista un respiro internazionale senza abdicare alla sua autenticità. Trasportando semmai anche oltreoceano quei valori di un popolo e di una terra, che poi, ed è questo quello che conta, si scoprono universali, come le foglie d’erba di Whitman (citato in una epigrafe) o come tutto ciò che parla direttamente alla parte più genuinamente umana di ciò che siamo e di ciò che possiamo o potremmo essere.
Nella prima parte, nella sezione dal titolo “Nei biancoscuri antefatti” si parla di cose e di oggetti, di lavori, di mestieri, alcuni dei quali quasi obsoleti, di sicuro antichi, molto poco globalizzati o globalizzabili: si parla di orti, di filari, di scalpellini, di giardinieri. Quasi a dire e a dirci che gli “antefatti” in realtà sono necessari e presenti. Poco dopo, per analogia e per contrasto, una sezione dedicata a simboli, quasi magici, allegorici, simbolici, e, alla fine della prima parte, “la deligittimazione”, tra favola amara e realtà, le guerre e le cornacchie, il campo del vivere messo a repentaglio.
Nella seconda parte il racconto in versi prosegue. Con una sezione con un titolo evocativo, con un rafforzativo interno: “Nell’aperto aperto Inferno”. Dante, ma anche i miti, draghi, tesori nascosti, Clitennestra, un repertorio di riferimenti per parlare del proprio tempo facendo appello a luoghi mitici. Anche per esorcizzare il dolore, mai spento, mai del tutto avulso, quella SLA d’amore, ad esempio, quella malattia che non può esser dimenticata ma che può diventare spunto per trovare nuovi parametri per la resistenza, ognuno sul proprio fronte, sulle trincee dei propri individuali mali, “contro il deserto che avanza/ unico amore che mi sostiene in questa/ guerra che mi pare persa in partenza – solo/ tu Stefania mia quotidiana epifania/ dittongo che inventa la mia resistenza/ ma tu non sai il peso di questo scudo/ le mie braccia vuote il mio cuore piegato/ la mia voglia di fuggire e trovare una fonte/ un sorso d’oasi che mi dia un po’ di calma ai polsi/ mentre mi scruti e lanci lividi spilli che conosco” (da Sla d’amore, pagina 116).
Si riparte poi, nella sezione finale, verso il “Nilo maggiore e minore”. La prima esplorazione è quella del tempo, il nodo fondamentale, con quel richiamo a quello che non è solo un fiume ma un mito reso acqua, movimento, cultura e fascino. Con una distinzione tra maggiore e minore che separa e unisce, unisce e separa. Così come gli eventi maggiori dell’esistenza si affiancano a quelli in apparenza minori fino al punto in cui il discrimine si perde e resta soltanto il sapore e il senso del fluire, dello scorrere verso un delta ignoto, che ognuno dentro di sé è tenuto a creare, o meglio a generare, come un seme gettato, una scommessa nel niente che può diventare una forma di esistenza.
Nella visione di Vaccaro, non solo poetica, il passato e il presente si intersecano, il mito è un modo per gettare luce, e calore, umano, sul presente, per cercare di comprendere, o almeno per non comprendere ma con un moto interiore più ampio, generoso. Parlando di luoghi distanti in realtà di ragiona sull’attualità, sul mondo di oggi, imperfetto, ingiusto e aspro, quello che Vaccaro mira a mutare, senza timore di accuse di idealismo, senza rinunciare a percorrere i sentieri delle utopie. È una rincorsa dura ma necessaria, una gara olimpica, un gioco serissimo, vitale. Come quello descritto a pagina 134, Ludi a Menfi : “tu ragazzo dagli occhi sfolgoranti/ a fare il sciuscià tra smorfie e canti/ nella polvere del mercato di Menfi/ e noi turisti disfatti a bere incantati/ il tuo ludente grumo di energia/ in filastrocche incomprensibili/ sulla pelle battenti più del sole –/ chi canterà nefertiti mia Afrodite/ la rosa della tua carne esplosa/ nella risata liberata da un bisturi/ di gioia – intelligenza che apre/ deridendo questa pancia di carne/ in scatola occidentale così colma/ di detriti ruggine e deserti”.
Il corpo come simbolo vivente, quella pancia occidentale che ormai deborda, a dispetto del mondo, dell’equità, della giustizia, ed è ormai piena di ruggine e deserti, deserti fatti di un pienissimo nulla, non quelli fascinosi ricchi di silenzi e di favolose visioni oniriche.
La vera natura, e il valore di maggior rilievo di questo libro, è la capacità di Vaccaro di porre fianco a fianco, adiacenti al punto di combaciare, il proprio mondo interiore e il mondo tout court. Il dolore altrui ma anche la bellezza autentica di popoli ancora spontanei e ricchi di umanità, quella che noi abbiamo perduto e perdiamo ogni giorno, non sono osservati con occhio distaccato o con sterile commiserazione. L’autore mette in parallelo il proprio essere con il mondo che percorre e che vede, ascolta, sente. Comprendendo, e forse è questo il consiglio, la richiesta, l’invito alla riflessione che ci deriva da questo libro, che gettare semi per se stessi è efficace, può dare frutti, soltanto se li gettiamo anche per gli altri. Non per generosità fine a se stessa, o per una presunta bontà, ma per un discorso più lineare: il mondo è un insieme di corpi e di voci, un organismo unico, in cui ogni singola parte è collegata alle altre. In un mondo come il nostro, in apparenza privo di speranza, la sola via di uscita è dare per riuscire ad avere qualcosa. Per ascoltarci, davvero, è la sola vittoria possibile arriva nel momento in cui riusciamo a sentire, nel senso della percezione più sincera, il grido altrui: Haiti è un urlo (pagina 140) : “Haiti è un urlo – l’ultimo/ di questa carne umana/ macinata dalla macina/ del dominio che decide/ senza domande chi nel mondo/ navigherà nell’oro o nella merda/ Il terremoto ha rotto il silenzio/ sulla infinita colonna in-fame di/ bambini in fila verso la bocca/ corrosa che li renderà liberi! – ma/ vedete come siamo trepidi e/ bravi nell’invio di soldati e/soccorsi/ Io giravo scalzo e senza/ pazienza senza consistenza/ senza accoglienza nemmeno del/ vento che mi braccava nella polvere/ come l’ultimo invisibile granello/ qual ero e nient’altro/ anch’io/ Che all’urlo d’ali della Terra/ bastò poco per sollevare/ fino a questi prati di cielo/ limpidi e senza limiti così/ pieni dello stesso niente che/ ero – finalmente angelo e/ libero”. IM
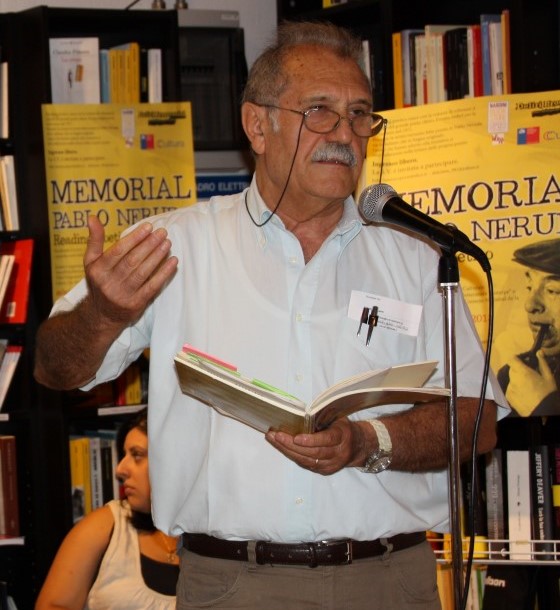
Adam Vaccaro, poeta e critico nato in Molise nel 1940, vive da più di 50 anni a Milano. Ha pubblicato varie raccolte di poesie: La vita nonostante, Studio d’Autore, Milano 1978; Strappi e frazioni, Libroitaliano, Ragusa 1997, con prefazione di Giancarlo Majorino; La casa sospesa, Joker, Novi Ligure 2003, con postfazione di Gio Ferri; e la raccolta antologica La piuma e l’artiglio, Editoria& Spettacolo, Roma 2006, con prefazione di Dante Maffia. Infine, Seeds, New York 2014, è la raccolta scelta da Alfredo De Palchi per Chelsea Editions, con traduzione e introduzione di Sean Mark. Ha realizzato inoltre varie pubblicazioni d’arte:, Spazi e tempi del fare, con acrilici di Romolo Calciati e prefazioni di Eleonora Fiorani e Gio Ferri, Studio Karon, Novara 2002; Sontuosi accessi – superbo sole, con disegni di Ibrahim Kodra, Signum edizioni d’arte, Milano 2003; Labirinti e capricci della passione, con acrilici e tecniche miste di Romolo Calciati e prefazione di Mario Lunetta, Milanocosa, Milano 2005; I tempi dell’orsa (2000) e Questo vento (2009) con opere di Salvatore Carbone, Edizioni Foto: Nicola Picchione – Firenze PulcinoElefante. È stato tradotto in spagnolo e in inglese.
Con Giuliano Zosi e altri musicisti, che hanno scritto brani ispirati da sue poesie, ha realizzato concerti di musica e poesia. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti (tra questi Premio Speciale Astrolabio, Pisa 2007, a La piuma e l’artiglio) ed è presente in molti Siti, blog e raccolte antologiche. Collabora a riviste e giornali con testi poetici e saggi critici. Per quest’ultimo versante, ha pubblicato Ricerche e forme di Adiacenza, Asefi Terziaria, Milano 2001, Premio nel 2001 del Laboratorio delle Arti di Milano, sez. saggistica. È tra i saggisti del Gruppo redazionale che ha curato Sotto la superficie – quaderno di approfondimento sulla poesia contemporanea de “La Mosca di Milano”, Bocca Editori, Milano 2004; e tra gli autori de La poesia e la carne, Edizioni La Vita Felice, Milano 2009.
Ha fondato e presiede Milanocosa (www.milanocosa.it,), Associazione Culturale con cui ha realizzato numerose iniziative. Tra queste: “Scritture/Realtà – Linguaggi e discipline a confronto”, di cui ha curato con Rosemary L. Porta gli Atti, Milanocosa 2003; “Bunker Poetico” in collaborazione con M. N. Rotelli alla 49a Biennale d’Arte di Venezia, giugno 2001, di cui ha curato con G. Guidetti la raccolta Poesia in azione, Milanocosa, Milano 2002; la 1^ Carovana Nazionale di Poesia e Musica (21-31 marzo 2003), promossa e coordinata con Anna Santoro e Maria Jatosti; evento col patrocinio del presidente della Repubblica e dell’UNESCO in corrispondenza della Giornata Mondiale della Poesia del 2003. Ha curato con F. Squatriti 7 parole del mondo contemporaneo, libro di Poesia, Arti visive, Musica e altre discipline, Milanocosa ed ExCogita, Milano 2005; Milano: Storia e Immaginazione, Milanocosa, Milano 2011; Il giardiniere contro il becchino, Atti del convegno 2009 su Antonio Porta, Milanocosa, 2012. Cura la Rivista telematica Adiacenze, materiali di ricerca e informazione culturale del Sito di Milanocosa.