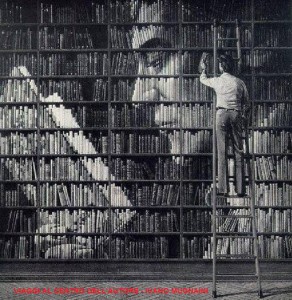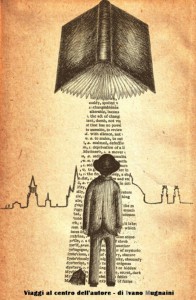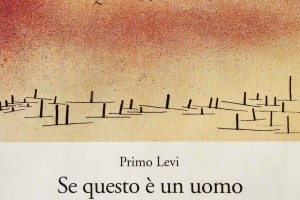Molti articoli, con diversi approcci e angoli visuali, sono stati scritti per ricordare Italo Calvino in occasione del trentennale della morte avvenuta a Siena il 19 settembre 1985.
Il presente omaggio a Calvino è in forma di “diario di viaggio”. Ho riesplorato varie tappe del suo percorso di uomo e artista, soffermandomi nelle città che ha amato e temuto e di cui ha colto il discrimine sottile tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile, se non nella magia di una “leggerezza” che unisce mito e realtà, sempre in un’ottica fertile e viva, profondamente umana. IM
————————————————————

A spasso con Calvino: nei luoghi, oltre i luoghi fino dentro la realtà
Se una notte d’autunno un lettore….
Se una notte d’autunno un lettore si trovasse a pensare a Calvino, alla sua fama, alla sua controversa ma innegabile attualità, alle polemiche a tratti aspre e in altri casi leziose che ne fanno comunque oggetto di dibattito come se avesse pubblicato oggi stesso un nuovo libro… ebbene, il suddetto lettore si troverebbe, alla fine, a riflettere su delle nuove o vecchie cosmicomiche.
Calvino è stato un “pianista” della parola. Ha saputo adattarsi con elasticità alle esigenze, ai temi, alle corde e agli accordi del suo essere e a quelli del mondo. Ecco, probabilmente è questa una delle possibili parole chiave: mondo. In primis per l’internazionalità autentica, genetica, che gli era propria. Non solo per la nascita nella caraibica Cuba, ma soprattutto per la capacità di esplorare continenti, lingue e mentalità diverse e farle proprie. Estremamente ligure in questo, con un piede sulla terraferma e uno proteso verso il mare, calmo o in tempesta, limpido o denso e scuro. Ma Calvino è stato e ha scritto del mondo soprattutto perché ha rifiutato di collocarsi nella proverbiale torre d’avorio. Ha percorso e abitato città reali, estremamente visibili, con quello sguardo attento e astuto da marinaio, tra sorriso ironico e amaro.
Di New York, Parigi, Roma e di mille altre luoghi visti e vissuti, ha colto il mito senza abdicare alla realtà, proponendo e rielaborando, mattone su mattone, una forma di verità che facesse pensare senza lacerare, conservando la capacità di spaziare tra presente e passato, tra la dimensione concreta e una giocosa, profondamente umana, filosoficamente infantile.
Di questi ossimori e questi paradossi si nutre la sua scrittura e l’attrazione che esercita. Talmente ampia da includere anche la sua controparte, le prese di posizione di alcuni detrattori che comunque fanno riferimento ai suoi testi, li analizzano e li dissezionano, dimostrando immancabilmente una conoscenza approfondita dei tessuti e delle arterie di quel corpo così multiforme. Calvino ha il dono e il castigo di generare giudizi divergenti. La mia stessa cerchia di amicizie letterarie riflette perfettamente il netto dualismo dei giudizi su questo autore. Un mio amico, ad esempio, molto colto e preparato, formidabile bevitore poco santo e parecchio logorroico, non molte sere or sono mi ha bloccato al tavolo di una cena per oltre un paio d’ore per dirmi, tra le altre cose, che a suo avviso tutta la produzione di Calvino non vale niente (anche se lo ha detto in termini più coloriti, abbondanti di lettere zeta) e che si salva solamente “Se una notte d’inverno”, proprio in quanto testo atipico, quasi un non-romanzo, una specie di ibrido alla Frankenstein, oppure un divertissement, insomma una “roba strana”, fuori schema. Pochi giorni dopo, in virtù della logica dell’alternanza, una mia amica scrittrice e giornalista mi ribadiva con foga, al contrario, il suo amore, non per me ma per il suddetto Calvino. Più che di amore si trattava e si tratta di vera e propria fede, laica, eppure dai connotati quasi integralisti. La giornalista dalle grandi doti comunicative aveva creato addirittura un club, un Circolo Pickwick di giovani scrittori di belle speranze, i quali, ispirandosi allo stile e ai temi cari a Calvino, avevano scritto un’antologia di racconti dal titolo “La consistenza”, con un’eco lunga e appassionata che riportava alle Lezioni americane da lei idolatrate e recitate brano dopo brano come versetti biblici o coranici.
Ebbene, a dispetto dei “Don Camillo” e dei “Peppone” nostrani, il viaggio di Calvino prosegue, come la scia del suo successo, fatto non solo di capacità di creare attenzione e far parlare di sè, ma anche e soprattutto di quel dono assai raro di intercettare e coinvolgere un pubblico vasto ed eterogeneo. Il piacere della lettura che non toglie nulla alla profondità del pensiero.
L’accusa di leggerezza è forse il più bel cameo che possa esibire, perchè stando alle sue stesse parole“…leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”.
Tutto questo per ribadire che la sua forza con ogni probabilità è in quella capacità di generare consistenza nell’inconsistenza e varietà nell’uniformità: giudizi contrapposti ma la stessa identica attenzione.

Un campionario ampio di pareri, soprattutto negativi, è stato raccolto e riportato in un recente articolo apparso sul Messaggero da Paolo Di Paolo. L’articolo, ampio e dettagliato, ha l’intento di mostrare la scarsa consistenza di alcuni giudizi. Uno dei punti cardine è quello in cui Di Paolo sottolinea che agli scrittori vengono perdonati eccessi, follie e stranezze ma raramente o quasi mai viene perdonato il successo. Questa è una colpa che non viene redenta, se non in casi rarissimi di scrittori morti giovani, possibilmente santi o martiri di qualche idea, meglio ancora se suicidi.
Calvino invece il successo lo inseguì, lo rincorse e lo raggiunse. Gradualmente, iniziando con un passo cadenzato, poi adattando il ritmo al percorso e ai tempi. Una delle svolte fondamentali fu quella di accettare il consiglio dell’entourage della Einaudi: quello di passare dal realismo alla letteratura fantastica. Molti altri scrittori si sarebbero sdegnati, avrebbero eretto bunker e barricate a difesa della propria impostazione. Calvino accettò il consiglio e lo tramutò nella propria forza. Sembrava che attendesse da sempre questo snodo, o meglio lo accettò come parte di sé e continuò a raccontare ciò che sentiva suo tramite invenzioni di macchine narrative fatte di castelli, visconti, numeri e formule create ex novo, luoghi inesistenti e in realtà radicati in ciascuno. Un’abilità camaleontica di parlare di sé diventando uno dei suoi numerosi personaggi, oggetti e luoghi, tra Marcovaldo e Palomar.
Calvino nasce a Cuba, ma vi rimane solo fino all’età di due anni. Il tempo necessario per assorbire di quella zona del mondo e di quella dimensione della mente un senso di precarietà tenace, un’allegria malinconica e una sete di avventura, fatta di incontri, di gesti, ma soprattutto di parole, racconti veri e inventati, esagerati ed esatti, come accade sempre in quella parte di continente in cui la realtà ha la voglia e la forza di farsi magia.
Il padre, agronomo sanremese, docente di matematica e scienze, conduce Calvino in Italia all’età di due anni. Il giovane si trova così a metà strada tra il mare e terra, intesa anche come suolo, studiato e misurato con criterio scientifico, e dall’altra parte il mare, l’attrazione dell’altrove. Successivamente Calvino rivisitò varie volte Cuba in compagnia della moglie, la traduttrice argentina Ester Judith Singer, sposata nel 1964. In quell’occasione conobbe Ernesto “Che” Guevara a cui, dopo la sua morte in Bolivia, dedicò alcune pagine.
A fianco a Cuba, di fronte, in un dialogo anch’esso complesso e fertile, l’America.
Ai primi di novembre del 1959 il trentaseienne Italo Calvino parte per l’America. Definisce New York, «la più spettacolare visione che sia data di vedere su questa terra». Qui, più che mai, il viaggio non solo parla della persona ma è la persona. Nel corso dei due mesi trascorsi a New York, Calvino realizza il desiderio profondo dei suoi personaggi, quindi suo: osservare il mondo senza essere visto, presente ed estraneo, invisibile e tuttavia concreto, tangibile, non meramente onirico.
Osserva l’America come suo padre avrebbe osservato e misurato un terreno complesso e irregolare, pieno di contrasti, arido e fertile, ricco di meraviglie e di desolazioni. Dalle sue “osservazioni” scaturiranno i saggi raccolti nel libro Un ottimista in America, edito da Einaudi. Nella primavera del 1961 il libro è pronto, ma Calvino lo ferma in seconde bozze. Si rende conto che il libro è troppo avanti e soprattutto troppo distante dai luoghi comuni acquisiti in Italia tramite le pellicole hollywoodiane: “Forse – dice – dovremmo insegnare agli americani che cos’è l’America”.

Calvino si sente americano, perfettamente a suo agio in una terra di contrasti, in evoluzione costante. È un uomo felice laggiù. Le lettere agli amici italiani sprizzano allegria. A Elsa Morante scrive: «New York mi ha assorbito come una pianta carnivora assorbe una mosca”. La fantasia nutre se stessa e divorandosi si rigenera, nuova, vitalissima. Quelle americane, ampie, dure, ma irrefrenabili nel brulicare di vita, sono il modello delle città invisibili, ognuna portatrice di un’idea, di un modello, di una potenzialità.
La Francia, inoltre, altro capitolo. A Parigi Calvino visse dal 1967 al 1980. È la città della sua maturità, il luogo dove prende atto della presenza fisica, rilevabile tramite i cinque sensi, della leggerezza, parola chiave, è giusto ribadirlo, e, più che mai, magica. Parigi è un racconto eternamente rivolto all’indietro, alla grandezza della storia e del passato ma con un piede etereo sospeso nell’aria, simile a quello di una ballerina della Folies Bergères, verso il futuro. La razionalità si inebria di effluvi di champagne e ne nasce l’umorismo, sensuale, in ogni possibile accezione.
In questa mappa ideale è utile fare sosta, con una passo indietro, anche a Torino, tappa significativa della sua giovinezza. Il capoluogo piemontese rivela, nella sua geometrica precisione di strade e gesti, uno dei contrasti alla base anche della scrittura e del pensiero calviniano: la città ha un vigore e una linearità che “invitano alla logica, e attraverso la logica” aprono “la via alla follia”. Non è un caso, detto tra parentesi, che Torino sia la capitale italiana del mistero e dell’occulto.
Roma, invece, apparentemente più posata e domestica, in realtà in qualche modo provoca in Calvino un’ammirazione prudente. Soprattutto a causa di alcuni scrittori dell’ambiente letterario della capitale che a suo avviso vi soggiornavano solo nella speranza di assorbire una grandezza che era loro estranea.
A Roma lo scrittore trascorse gli ultimi cinque anni della sua vita, alloggiando in piazza Campo Marzio. Rileggendo alcune pagine di Palomar dedicate a Roma vi si intuiscono presagi di morte che paiono quasi assediare il protagonista in fuga dalla folla. Ne «L’ invasione degli storni», c’è un espediente narrativo e psicologico di geniale efficacia: la città eterna vista «con occhi da uccello». I secoli trascorsi e l’istante che fugge.
Calvino-Palomar evita di confrontarsi con la città reale. Guarda in alto, fuori dalle prospettive consuete e si chiede se “questo affollarsi del cielo ci ricorda che l’ equilibrio della natura è perduto? O perché il nostro senso di insicurezza proietta dovunque minacce di catastrofe?” Scriveva Pasolini: “le città che Calvino sogna, in infinite forme, nascono invariabilmente dallo scontro tra una città ideale e una città reale”. In quest’ottica, dunque, Roma, la più nota delle metropoli, quella in cui tutto, passato e presente è alla portata degli occhi, dei piedi e delle mani, in realtà è l’ultima, e la prima in ordine gerarchico, delle città invisibili incontrate ed evocate da Calvino. E se Calvino è visto come “scrittore freddo”, accusato di essere incapace di rendere il senso del tragico e del sacro, è proprio perché la sua visione assolutamente laica, priva di religiosità, lo spinge a rinunciare al lusso delle illusioni, quelle in cui indulgono coloro che esaltano un passato glorioso o un lontano futuro di redenzione. In Calvino non c’è illusione. La sola gioia possibile è quella di un reale reso mitico dall’energia presente e da una fantasia che non pretende di ammantarsi di vesti sacre o mistificatorie.

In questo breve excursus sul percorso umano e letterario di uno degli autori italiani più apprezzati e letti in tutto il mondo, ho provato anch’io a “planare sulle cose dall’alto senza macigni” ideologici o preconcetti ma tentando di offrire una ulteriore chiave di lettura della sua produzione letteraria. Tentativo un po’ folle, vista la vastità e la varietà di spunti e tematiche che gli sono proprie. È stato quasi come ricercare i sentieri dei nidi di ragno, tanto per prendere a prestito il titolo del suo primo romanzo. Tentativo folle, e quindi in fondo compatibile con l’atteggiamento di un autore che ha saputo cercare la natura autentica dei luoghi e dei personaggi, proprio nell’atto di evidenziarne l’imprevedibile umana follia, senza le barriere preconcette del prima e del dopo, del se e del mai.
Calvino ha cercato l’affermazione di sé e del proprio mestiere senza snaturarsi, senza rinunciare alla coerenza con ciò che credeva e ciò a cui non credeva, senza dogmi e costrizioni. Il suo successo non è una colpa né può essere visto come un limite. Forse anzi è la prova ulteriore che, per parlare della realtà, non c’è spazio più grande della fantasia. È la testimonianza che ciascun individuo è una città di parole e sogni, invisibili fino a quando non accettiamo il mistero del connubio del sorriso e del pensiero. Quel gioco per cui ogni vita è solo se stessa ed è parte di un mito e di un mistero. Calvino ricorda, con i suoi libri, ad ogni individuo rampante, dimezzato, cosmicomico, incessantemente viaggiante, che quel gioco va vissuto e raccontato, giorno per giorno. Perché la vita è un luogo che si trasforma istante per istante, nell’atto di viverlo, pensarlo e immaginarlo: “Arrivando a ogni nuova città il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva più d’avere”. Quindi, tornando alla citazione da cui siamo partiti: “Se una notte d’inverno un viaggiatore, fuori dall’abitato di Malbork […] in una rete di linee che s’intersecano illuminate dalla luna”, chiede ancora: “Quale storia, laggiù, attende la fine?”, la risposta, sempre diversa, sempre individuale e nuova, è nel racconto stesso, nascosta e palese, misteriosa e lineare, profonda ed eternamente leggera.


Questo specifico articolo, così come molti altri saggi e testi che ho scritto da un anno a questa parte, sono stati ispirati, coordinati e realizzati grazie alla collaborazione di un’autrice che mi ha chiesto di rimanere anonima finché non sarà portato a termine il progetto editoriale connesso e a cui va la mia gratitudine.
Ivano Mugnaini