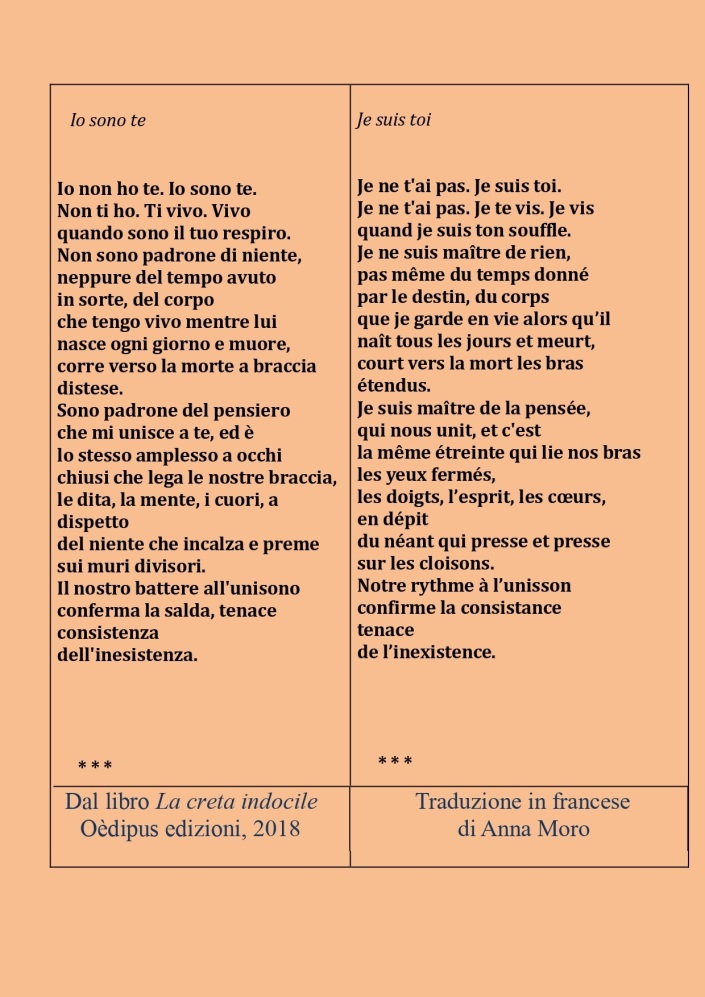DRAMATIS PERSONAE:
SHAK : William Shakespeare
BURB : Richard Burbage, principale interprete dei maggiori lavori teatrali di Shakespeare
MARY : Mary Winifred Burbage, moglie di Richard Burbage

SHAK : La notizia è ufficiale: è morto Christopher Marlowe. Uno dei due maggiori autori del suo tempo. L’altro è ancora vivo, e, spero, lo rimarrà ancora a lungo!
BURB : E’ possibile William che tu non riesca a comportarti come si deve neppure di fronte alla morte?
SHAK : Come no? Ci riesco perfettamente. Faccio ciò che si deve. Ciò che si adatta alla morte. Anzi, esattamente il contrario. Se resto me stesso, se non cambio, rimane vivo anche Christopher. Se scherzo come se fosse in vita, e lo amo e lo odio come prima, Christopher c’è ancora. E ancora sopravvivono i suoi scritti, le sue parole. E’ qui, con noi, lo è stato, lo è e lo sarà. Sì, viva quel figlio di un cane di Christopher Marlowe!
[Esce Shakespeare, cantando versi sconci]
BURB : Non riesco a capirlo. È un uomo fatto di nulla, di fiato, di aria impalpabile.
MARY : Ogni uomo è fatto a suo modo. William è le sue parole.
BURB : È stato lui ad ucciderlo! Ne sono convinto. Ora più che mai.
MARY : Ma cosa dici, Richard?
BURB : So bene cosa dico, lo so alla perfezione. William ha sempre odiato Marlowe. Lo ha sempre considerato un ostacolo, un impedimento. Ora, togliendolo di mezzo, si è spianato la strada per la gloria e il successo. Marlowe era l’unico in grado di tenergli testa. Anzi, forse gli era superiore per ispirazione e inventiva. William lo ha fatto assassinare da un sicario in una rissa di taverna. Marlowe era facile all’ira, è stato facile attirarlo in un tranello.
MARY : Stai dicendo cose senza senso, Richard.
BURB : Magari fosse così! Ne sarei felice. Ma si tratta solo della verità. La realtà nuda e cruda. Tolto di mezzo il rivale, William può volare solitario nei cieli della fama. Era un pollastro di campagna, un gallinaccio impolverato di Stratford, ancora mezzo sporco di letame. Ora, grazie al teatro, grazie a me, alla voce e alla faccia che gli presto da anni, si è potuto rivestire di piume nobili d’aquila e di falco. E di falco ha sviluppato anche gli artigli e la cupidigia. Ha eliminato Marlowe senza alcuna esitazione. Un taglio netto alla gola, una ferita mortale. Ma William è un falco astuto, civilizzato. Non si è sporcato di sangue. Lo ha fatto fuori per interposta persona.
MARY : Non credo a una sola parola di quello che dici! Marlowe è sempre stato una testa calda. Non ha fatto altro che mischiarsi ai delinquenti, alla peggiore feccia. È chiaro che presto o tardi un incidente del genere poteva accadergli. Si è trattato solo di una disgrazia, e Marlowe ha fatto di tutto per andarsela a cercare. Perché ti accanisci contro William? Sono certa che anche lui, a suo modo, soffre per la scomparsa di Marlowe. Come puoi accusarlo in questo modo? E perché proprio adesso? Hai sempre amato William, lo hai sempre rispettato. Cosa è cambiato ora?
BURB : Non è cambiato niente, è questo il punto. Solo che, in questo preciso istante, mi ha colto un senso di vertigine, la coscienza del vuoto. Mi sento sull’orlo di un baratro, e l’aria, adesso, pesa come pietra. Sono stanco di recitare. La morte trasforma le cose. Ti penetra dentro e ti cambia, anche quando non è la tua. Perché la morte è di tutti, identica, democratica, giusta, inesorabile. Marlowe lo conoscevo appena. Non ho mai recitato in un suo dramma, non ho mai parlato con lui. Però ho ascoltato le sue parole. Le ho fatte mie. I suoi versi, le ambizioni, le tragedie, le miserie e le grandezze. Sera dopo sera, mentre davo vita a Enrico IV, a Riccardo III e a Tito Andronico, dentro di me sentivo crescere l’urlo di rabbia di Faust e Tamerlano, la loro sete di potere e di conquista. Diventavo Marlowe, mentre recitavo, frase per frase, i testi cesellati da William.
MARY : È normale, Richard. Sei un attore, ma hai diritto anche tu, come tutti, ai tuoi pensieri e ai sogni al di fuori della scena. È giusto conservare spazio per il mondo autentico, le passioni reali, le verità.
BURB : Già, è normale. Ma mio padre mi ha portato su un palcoscenico molto prima che fossi in grado di parlare e camminare. Facevo la parte del neonato rapito dai pirati. Mi infagottavano in un drappo azzurro e mi sballottavano da una parte all’altra. Dalle braccia dell’attrice che impersonava mia madre a quelle dei guitti vestiti da bucanieri. Piangevo, atterrito. Una recitazione perfetta, del tutto adeguata al ruolo. Ecco, posso dirti che i primi versi che ho recitato sono stati i singhiozzi di un pianto. E quelle sono state le prime e le uniche volte in cui la mia parte è stata sincera. Le sole volte in cui la finzione ha combaciato con la vita. Solo che non avevo coscienza, ero un bimbetto frignante, incapace di pensare. Capace soltanto di sentire paura e dolore. Ho potuto ragionare solo in seguito su quella beffarda ironia. Solo più tardi, quando ero già un attorino giovane, solerte, rispettoso del testo alla virgola, attento al ritmo, alle pause, alle entrate in scena e alle uscite imposte dal copione. Sono stato sincero, in vita mia, solo quando non lo sapevo. Quando esprimevo la sofferenza per istinto, come un qualsiasi animale. Dopo, per anni, per lunghe stagioni di esordi e di repliche, sono stato sempre e soltanto un fantoccio. Pieno di vento e orgoglio, carico di gesti e follie generate da altre mani, altre menti. Sangue e inchiostro alieno. Sono stato William Shakespeare, per anni interi. I suoi eroi, i bellimbusti, i condottieri, i Romani, gli Ebrei, i Veneziani, i vincitori e vinti della sua fantasia. Tutti trionfanti, alla fine, gli uni e gli altri. Acclamati dal pubblico, osannati, imitati. Sono stato William Shakespeare. Restando me stesso, però, un sacco vuoto colmo di echi nudi di parole. Poi, un giorno, è giunta a me la voce di Marlowe. Ho scoperto che esisteva qualcosa, qualcuno in grado di coprire quell’eco con un grido possente. Qualcuno più forte, più folle, più dotato di disperato talento. Ho lasciato che la voce di Christopher crescesse in me, sera dopo sera, spettacolo dopo spettacolo in un vitale e distruttivo controcanto.
MARY : Ora capisco la ragione del tuo dolore. Ma non puoi lasciarti accecare dalla rabbia. Marlowe è morto, ma restano le sue parole, le invenzioni, la verità. La verità, sì. Bisogna averne rispetto, conservarne la natura, lo spirito profondo. Non puoi accusare William. C’è un confine netto tra realtà e finzione, ragione e follia. È la verità, che ti piaccia o no. Bella o brutta, dolce o agra come veleno, è necessario riconoscerla, rispettarla; è il solo dio, la verità, che si concede alla nostra vista. Si tratta di chinare la testa, guardarlo negli occhi un istante, e venerarlo una vita intera.
BURB : Hai ragione. Hai sempre ragione, Mary. Bisogna venerare la verità. È un comandamento, una necessità. Allora, finalmente, mi inchino. Grazie a te ne trovo la forza. Mi genufletto, davanti a te, che sei il mio amore, la sola persona in cui posso specchiarmi senza vedere il baratro della distanza e dell’indifferenza. Dono a te la mia verità, ad occhi chiusi, piangendo, come quando ero un fagotto di carne conteso da braccia sconosciute sulle tavole di un palcoscenico. Piangendo e gridando, ti regalo la verità che desideri. Ma è un dono che faccio soprattutto a me, ad essere onesto. Liberandomene, mi sgravo del fardello di me stesso.
Christopher Marlowe l’ho ucciso io. Sì, io, Richard Burbage, attore ricco e famoso. Non è stato difficile, in fondo. Ho solo indossato un travestimento in più, un tabarro scuro con un cappuccio che mi copriva la faccia lasciando scoperti solo gli occhi. Ho impersonato la parte di un cupo e taciturno sicario. Ho provocato Christopher quel tanto che è bastato per costringerlo a reagire. L’ho sopraffatto, colpendolo più volte ai fianchi, al petto, al cuore. Ho guardato il suo sangue colare a fiotti. Sono scappato via, gettando il mantello tra gli arbusti di una boscaglia. Sono andato a passi lenti, poi, da aristocratico in gita di piacere, fino alla cittadina più vicina. Ho preso una carrozza e sono tornato a casa, sereno, pulito.
Tutto facile. Anche raccontarti, fin qui, cosa ho fatto. Più complesso, molto di più, è parlarti dei perché. Potrei dirti che per William ho provato immediatamente un’istintiva antipatia. Mi è sempre risultato indigesto, lontano, incompatibile con il mio modo di vedere e pensare. Christopher, invece, lo amavo. O meglio, cominciavo ad amarlo. Sentivo nascere in me quella passione, quella comunanza che ti fa riconoscere nell’altro, fino a sentirlo dentro, percependo te stesso in lui. Cominciavo ad amarlo. E ho dovuto fermare quell’amore. Ad ogni costo. Perché sarebbe accaduto come con William: mi sarei accorto di non essere nulla al suo confronto. Il paragone mi avrebbe annichilito. Solo che, nel suo caso, l’amore sarebbe stato un ulteriore carico, un macigno in più. Posso sopportare di essere il fantoccio di stracci di qualcuno che mi sta indifferente o che odio, ma non riesco ad esserlo nei confronti di qualcuno che amo. L’abisso di distanze tra il desiderio e la realtà mi avrebbe schiacciato, tramutando la mia mente in poltiglia. L’ho ucciso per salvarmi. C’è qualcosa di più forte della pietà umana, dei dettami della morale; qualcosa di più forte dell’orrore, e perfino dell’amore: l’egoismo, il grido assordante dell’istinto di sopravvivenza. Chiamala come vuoi, anche solo pazzia, magari. Qualunque nome gli diamo, non muta la sua essenza.
È questa la verità che volevi. La sola, l’unica che mi è stata data in sorte in questo “racconto pieno di rumore e furia narrato da un idiota”. Ecco, vedi, neppure in questo momento riesco a smettere di recitare. Sono e rimango un attore, è condanna e privilegio. Forse anche tutto ciò che ti ho confessato è una fandonia. Il mio tentativo personale di creare una vicenda di cui, per una volta, sono anche il regista e l’autore. Certo, magari è così. Decidi tu. Il compito è tuo, adesso. Ora sei anche tu un’attrice, amore mio. Attrice e sceneggiatrice costretta a far combaciare la faccia con la trama. Quella che pensi di architettare pagina dopo pagina, atto dopo atto, e che spesso, al contrario, si scrive da sola. La vicenda nasce nell’atto di recitarla, mentre, magari, pensi a qualcos’altro, o provi a sperare un epilogo diverso. Ma questa è un’altra storia, vecchia, risaputa. Riguarda ciò che rimane, ciò che si salva, e che, spesso, non salva te.
“Il resto è silenzio”, scrive il grande William Shakespeare. E, come sempre o quasi, ha ragione lui. Il silenzio è cosa buona e giusta, è pietoso, generoso. Lo affermo io, contro il mio interesse, io che vivo di fiato e suono di parole. Il silenzio è pietoso, ma tu, amore mio, hai voluto ascoltare il frastuono di metallo della verità. Ora anche tu ne ascolti il clamore. Devi muoverti, correre su tavole impolverate, per non sentirlo più, o fingere con te stessa di non sentirlo. Devi scegliere anche tu, da questo preciso istante, la verità che vuoi e puoi sostenere, quella che ti consentirà di campare, venendo a patti con la vita, fino alla scommessa scontata e persa con qualche sollievo, la morte.
Scegli tu la verità, Mary. Traccia il confine, la linea rossa di vernice e sangue tra realtà e finzione. Adesso siamo davvero uniti per il bene e per il male, amore mio. Facciamo la stessa strada, sotto un cielo che ti scruta senza mollarti un istante. Fai la tua scelta. Dovrai decidere anche tu quale realtà percorrere, da quale cammino lasciarti attraversare. Anche tu ora, come me, dovrai dire a te stessa, istante dopo istante, se sei bugiarda oppure assassina”.
 Richard Burbage, amico di William Shakespeare
Richard Burbage, amico di William Shakespeare